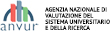Proposte
Lista di controllo per la predisposizione di una proposta
Durante la procedura di trasmissione di una proposta, gli autori devono verificare il rispetto dei seguenti requisiti; la submission potrebbe essere rifiutata se non aderisce a queste richieste.- Il testo non supera il limite dei caratteri stabilito: massimo 40.000 per gli articoli (spazi, note e bibliografía compresi) e 8.000 per le recensioni.
- Il testo rispetta le norme tipografiche (tipo e corpo caratteri, ecc.) indicate nelle Linee guida per gli autori.
- Il testo rispetta le norme per le citazioni (norme APA).
- Inserimento di una versione dell’articolo pronta per la revisione cieca.
- Abstract (massimo 150 parole), parole chiave (massimo 8) e lista di riferimenti bibliografici sono pronti per essere caricati durante il processo.
Informativa sui diritti
Gli autori i cui contributi vengono pubblicati dalla rivista sono d'accordo per quanto riguarda i seguenti termini:- Gli autori conservano i diritti di autore
- I testi pubblicati nella rivista sono sottoposti, se non indicato diversamente, alla licenza di Riconoscimento-non commerciale 4.0 Internazionale di Creative Commons. Possono essere copiati, distribuiti e comunicati pubblicamente, nonché adoperati in altre opere, purché ne vengano riconosciuti i crediti (autore, nome rivista, istituzione editrice) nei modi specificati dagli autori o dalla rivista. La licenza completa è consultabile nel sito https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
- Gli autori sono autorizzati a prendere ulteriori accordi indipendenti per la distribuzione non-esclusiva della versione pubblicata nella rivista (come ad esempio in un repositorio istituzionale o in un libro), purché se ne riconosca l'originale pubblicazione nella rivista.
- Gli autori sono incoraggiati a pubblicare l'opera online (in repositori istituzionali o nel proprio sito web, per esempio) prima e dopo il processo di pubblicazione, con lo scopo di ottenere scambi produttivi e aumentare il numero di citazioni dell'opera (vedasi The Effect of Open Access).
Informativa sulla privacy
Use of the UAB's website and any of the services it offers implies full acceptance of the terms stipulated by the following data protection policy.
1. Data Collection and Consent
In compliance with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR), we herein inform users that the personal data requested in our forms or that might be provided via our email addresses, based on unambiguous explicit consent, is included in our personal data files for which the UAB is the owner and responsible. Thus, when filling in any of the forms with the personal data requested and accepting its being sent or sending us an email with personal data, the user expressly authorizes and consents to the UAB processing and incorporating this personal data provided and all the data generated from the user's participation or use of the different products or services offered on this website, though this may be revoked but not with retroactive effects, and accepts the data processing terms set out below.
Likewise, we inform users that all data shall be processed confidentially and in accordance with the data protection legislation in force, and that our files are legally registered in the Catalan Data Protection Agency's General Register.
The UAB accepts no responsibility for personal data processing on web pages that users access via the different links to be found on our website.
This website is regulated by the legislation exclusively applicable to Spain, to which users of this website, whether in Spain or abroad, shall be subject.
2. Uses
The data requested are adequate, pertinent and strictly necessary for the ends for which they are collected, as sending news through email given or recognize in future visits. They shall never be used for an end other than that for which they have been ceded and, under no circumstances, shall the user be obliged to provide us with them. Nonetheless, they are absolutely necessary for the development of the services offered.
Unless specifically stipulated otherwise, all the fields on all the forms need to be filled in. Users must fill in the forms with true, accurate, complete and up-to-date information. The user is solely responsible for any damage or prejudice, whether direct or indirect, that may affect the UAB or any third party due to filling in forms with false, inaccurate, incomplete, outdated or third-party information.
Our website obtains users' personal data by receiving different forms or emails to manage subscriptions to our journal or, where applicable, due to participation as an author, editor or reviewer, based on unambiguous explicit consent.
The UAB reserves the right to decide to incorporate, or not, these people's data into its files.
3. Users' Right to Access, Rectify and Cancel Personal Data
Those involved in editing this journal seek to be compliant with industry standards for data privacy, including the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) provision for “data subject rights” that include (a) breach notification; (b) right of access; (c) the right to be forgotten; (d) data portability; and (e) privacy by design. The GDPR also allows for the recognition of “the public interest in the availability of the data,” which has a particular saliency for those involved in maintaining, with the greatest integrity possible, the public record of scholarly publishing.
The user has the right to request cancellation of the subscription, access the information held in the UAB's files, declared at Data Protection Register of Catalonia, rectify erroneous information, cancel it or oppose its processing, in the terms established by the Law. To do so, they must email sp.revistes.digitals@uab.cat.
Authors' requests for cancellation of data shall not affect their articles published on the website, in line with authors' unlimited cession of copyright to the UAB.
If you do not expressly cancel your personal data from our files, we shall assume you are still interested in remaining on file while this remains appropriate for the ends for which they were obtained and while the UAB deems appropriate.
4. Security
The UAB, in response to the trust placed in us and taking into account the importance of protection and confidentiality of users' personal data, hereby informs you that we have adopted all the technical and organizational measures to safeguard security as required by the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) in force on security of files containing personal data.
5. Cession of Data
We inform you that your data are processed confidentially and used for the ends indicated, and only communicated in the cases covered by the legislation and to bodies who, alongside the UAB, produce the journal, as shown on the website, and manage and collaborate in the journal's publication.
Personal metadata related with a published article (name and surname, profesional affiliation, ORCID number, country) are deposited and distributed, associated with an article, in order to assign a DOI through Crossreff.
The UAB provides users different recommendation options, which are the sole responsibility of the person sending the message. The UAB accepts no responsibility for the sending of unsolicited commercial mailings. Under no circumstances do we keep the recipient's email address. Likewise, batch sending of messages by users via these options is strictly prohibited, as is any commercial use.
6. Cookies
The UAB communicates to users, through this notice, that it uses cookies when the user accesses the different screens and pages that make up the site. The cookies used by the UAB are stored on the user's hard drive, but cannot read data contained thereon nor read the cookies created by other providers. The UAB uses cookies in order to recognize users who have registered and so as to offer them a better, more personalized service (the user's preferred language, etc.). They are also used to obtain completely anonymous information about access data (date, hour, minute, frequency, etc.), so as to be able to measure certain traffic parameters for the website itself and calculate the number of visits made, so that the UAB can focus and adjust the services offered most effectively. Despite this, the user may stop the generation of cookies by using the corresponding option offered by their browser. In this case, the website shall remain operative, but without the advantages offered for personalization.
7. Mailings
In compliance with article 21 of the Law on Information Society and E-commerce Services, which prohibits commercial mailings unless they have been expressly authorized by the recipients in advance, we hereby inform you that by accepting the terms of use and data protection policy, you expressly authorize informative, commercial, advertising and promotional mailings to the address provided. Nonetheless, if you do not wish to receive our commercial mailings, you can request cancellation following the instructions given in each mailing.
8. Modifications of this Data Protection Policy
This data protection policy was established on 5 May 2018. The UAB reserves the right to modify its data protection policy in future in accordance with its own criteria or due to a change in the legislation, jurisprudence or business practices. If the UAB introduces any changes, the new text shall be published on this same page, where the user is provided with information on the data protection policy. In any case, the relationship with users shall be governed by the regulations in force at the precise moment when they access the website and, as a result, they must be read every time users provide their data via our website.